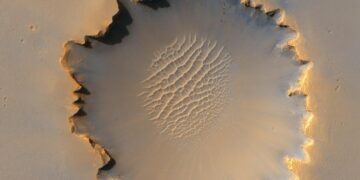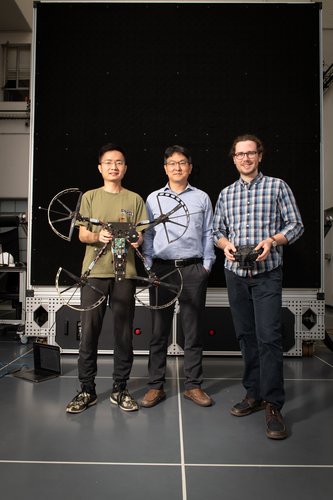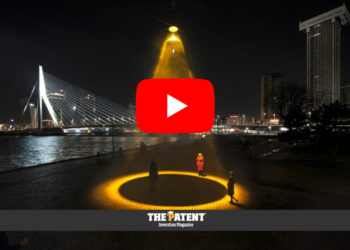Trentatre anni fa, il disastro nucleare in Ucraina, che ha posto l’umanità davanti al problema della sicurezza delle centrali atomiche
Il 26 aprile è una data che ha unificato il concetto di energia nucleare “cattiva”, quella degli ordigni atomici, della corsa agli armamenti della Guerra Fredda, e quella “buona” rappresentata dalle centrali nucleari che, dopo la metà del ‘900, si sono moltiplicate a dismisura in tutto il mondo. Due concetti che, fin dalla scoperta dell’atomo, erano stati sempre ben distinti. Nel 1986, però, ci si fermò a ragionare sulla bontà dell’idea.
 Il freno a mano fu tirato dalla più grande catastrofe nucleare al mondo, l’incidente della centrale di Chernobyl, in Ucraina. Incalcolabile il numero di morti, a distanza di decenni, a causa delle radiazioni, 66 operatori della centrale, deceduti a distanza di pochi giorni per avvelenamento da radiazioni, 1057 soccorritori, che si occuparono delle operazioni di emergenza per il contenimento del disastro nelle prime ore successive all’incidente, operando al limite, con il dosimetro che spesso arrivava a fondo scala. A distanza di 11 anni, dal disastro, dopo la costruzione di un primo scudo contro le radiazioni, completato a tempo di record nel dicembre del 1986, il mondo intero si rese conto del pericolo rappresentato da questa bomba a orologeria, giungendo, nel 1997 in occasione del G7 a Denver, alla fondazione della Chernobyl Shelter Fund per raccogliere fondi per mettere in sicurezza il reattore. Un progetto che prevedeva la costruzione di un nuovo sarcofago, più moderno e di diversa concezione, in grado di inglobare quasi interamente la struttura.
Il freno a mano fu tirato dalla più grande catastrofe nucleare al mondo, l’incidente della centrale di Chernobyl, in Ucraina. Incalcolabile il numero di morti, a distanza di decenni, a causa delle radiazioni, 66 operatori della centrale, deceduti a distanza di pochi giorni per avvelenamento da radiazioni, 1057 soccorritori, che si occuparono delle operazioni di emergenza per il contenimento del disastro nelle prime ore successive all’incidente, operando al limite, con il dosimetro che spesso arrivava a fondo scala. A distanza di 11 anni, dal disastro, dopo la costruzione di un primo scudo contro le radiazioni, completato a tempo di record nel dicembre del 1986, il mondo intero si rese conto del pericolo rappresentato da questa bomba a orologeria, giungendo, nel 1997 in occasione del G7 a Denver, alla fondazione della Chernobyl Shelter Fund per raccogliere fondi per mettere in sicurezza il reattore. Un progetto che prevedeva la costruzione di un nuovo sarcofago, più moderno e di diversa concezione, in grado di inglobare quasi interamente la struttura.
 Realizzato a partire dal 2010 e posizionato sulla centrale nel 2016, il NSC (New Safe Confinement), è operativo dal febbraio di quest’anno. Adesso sarà possibile effettuare i lavori di smantellamento e di demolizione delle strutture instabili, contenendo, in caso di collasso del vecchio sarcofago, le polveri radioattive che saranno rilasciate in caso di crollo. Un miliardo e mezzo di dollari impiegati per la costruzione, 275 metri di lunghezza e 108 di altezza, fanno dell’NSC un vero prodigio dell’ingegneria e la più grande struttura mobile mai costruita dall’uomo. Sì, perché questa cupola è stata realizzata a un centinaio di metri dal mostro nucleare e poi spostata in loco utilizzando dei binari.
Realizzato a partire dal 2010 e posizionato sulla centrale nel 2016, il NSC (New Safe Confinement), è operativo dal febbraio di quest’anno. Adesso sarà possibile effettuare i lavori di smantellamento e di demolizione delle strutture instabili, contenendo, in caso di collasso del vecchio sarcofago, le polveri radioattive che saranno rilasciate in caso di crollo. Un miliardo e mezzo di dollari impiegati per la costruzione, 275 metri di lunghezza e 108 di altezza, fanno dell’NSC un vero prodigio dell’ingegneria e la più grande struttura mobile mai costruita dall’uomo. Sì, perché questa cupola è stata realizzata a un centinaio di metri dal mostro nucleare e poi spostata in loco utilizzando dei binari.
Una struttura tubolare in acciaio rivestita da tre strati di pannelli, costituita da due archi, distanziati da una intercapedine di 12 metri, che assicura lo scambio continuo di aria, e che è in grado di resistere a venti fino a 170 km/h. Anche un po’ di Italia è presente in questo progetto. Gli elementi in acciaio dello scheletro, sono stati forniti dalla Cimolai di Pordenone, che ha prodotto 25mila tonnellate di tubi metallici. Assemblati a terra, i tre elementi che costituiscono gli archi sono stati poi sollevati e fissati con un numero infinito di viti e bulloni, dopodiché la sezione di arco è stata poi posizionata sui binari con l’aiuto di martinetti idraulici.